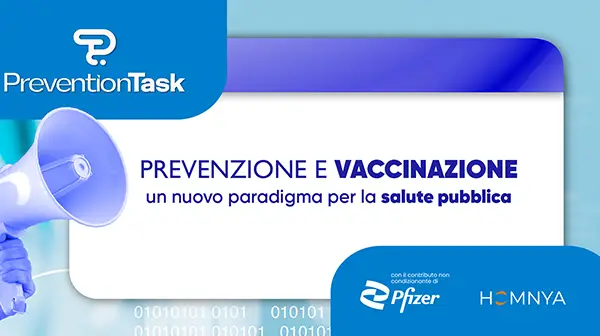Alle vaccinazioni è dedicato il primo appuntamento di Prevention Task, il nuovo progetto editoriale di Homnya dedicato alla prevenzione primaria. L’obiettivo è contribuire a rafforzare la cultura della prevenzione nel nostro Paese e ad indagare gli ostacoli a quegli strumenti (vaccinazioni, screening, stili di vita…) che sono le prime armi (e le più efficaci) di sanità pubblica e di salute pubblica
La prevenzione primaria rappresenta il primo presidio per la tutela della salute pubblica e per la sostenibilità del sistema sanitario. Ma in un contesto di risorse limitate e crescente domanda di servizi, la prevenzione si conferma anche una leva cruciale per l’efficienza e la sostenibilità del sistema salute. Tra le strategie più prevenzione più efficaci un posto d’onore spetta sicuramente ai vaccini, che negli anni hanno permesso di eradicare molte terribili malattie ma anche di ridurre drasticamente la diffusione di infezioni gravi, salvando vite e riducendo il ricorso alle cure ospedaliere e farmacologiche. Eppure qualcosa si è inceppato. Perché negli ultimi anni, la crescente disinformazione o l’idea che non ci sia più pericolo sta compromettendo i risultati raggiunti grazie ai vaccini. Come invertire la rotta? Come rendere la prevenzione sempre più protagonista nel nostro Paese?
Di tutto questo si è parlato in occasione della prima puntata di Prevention Task, il nuovo progetto editoriale di Homnya dedicato alla prevenzione primaria, promosso con il contributo non condizionante di Pfizer.
Ospiti del talk, condotto da Corrado de Rossi Re (Direttore responsabile di Sanità Informazione), sono stati Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Ssn del ministero della Salute; Anna Teresa Palamara, Direttore Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss); Fabrizio d’Alba, Presidente Federsanità Anci e Direttore Generale del Policlinico Umberto I di Roma; Pier Luigi Lopalco, Professore Ordinario di Igiene all’Università del Salento ed ex assessore alla Salute della Regione Puglia; Francesco Macrì, segretario nazionale della Federazione italiana delle Società medico-scientifiche (Fism); Ugo Trama, Vicepresidente Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici (Sifo) e Responsabile Politiche del Farmaco della Regione Campania; e Ketty Vaccaro, Responsabile Area Welfare e Salute del CENSIS.
Le premesse sono evidenti: quella in cui viviamo è un’epoca segnata da uno straordinario progresso in termini di ricerca scientifica e i benefici delle vaccinazioni sono dimostrati da anni da un numero enorme di studi scientifici anche recenti. Eppure basta poco per creare allarmismo sui vaccini e il preoccupante calo della copertura vaccinale lascia pensare che tra i non vaccinati ci sia anche chi non ha nulla contro i vaccini, però evidentemente non percezione l’utilità (almeno per se stesso).
“Il modo in cui si comunica, in sanità, conta molto. Non è un caso se oggi l’Oms definisce la comunicazione un vero e proprio intervento di sanità pubblica”, ha esordito Anna Teresa Palamara. “Ovviamente non sempre la comunicazione avviene in modo corretto o efficace. L’esperienza del Covid ce lo ha insegnato: non basta dire cose giuste, conta ciò che le persone percepiscono e se quello che comprendono è distante dalla verità scientifica, significa che il messaggio è stato veicolato male e bisogna trovare nuove parole e strategie”
Il Direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ha però posto l’accento anche su un altro aspetto: “La scienza è basata sull’evidenza ma questa evidenza non è necessariamente qualcosa di statico e definitivo. La scienza evolve e spesso dà luogo ad nuove evidenze che possono anche modificare quella originaria. Bisogna riuscire a far capire alle persone che è normale e non significa che si scienziati si stiano contraddicendo, ma solo che ne sanno un po’ di più, che la conoscenze si sono evolute e questo è un bene”.
In definitiva, per Palamara, la parola d’ordine è “imparare a collaborare, a discutere, a capire anche le obiezioni”. Per far questo occorrono dei professionisti e una collaborazione stretta e continua tra chi si occupa di scienza e chi si occupa comunicazione e sa come rendere le informazioni scientifiche fruibili da un grande pubblico. Ed è quello che l’Iss è impegnato a fare: “L’Istituto è attivo sul territorio dal 1934, ha una lunga storia a fianco della sanità pubblica, una storia che mette insieme ricerca (quindi capacità di trovare anche soluzioni innovative) e sanità pubblica (quindi capacità di attuare queste soluzioni innovative). È un’istituzione che si pone a fianco delle istituzioni, delle Regioni e dei professionisti, per diffondere salute attraverso una collaborazione che già esiste e che abbiamo il dovere di preservare”.
Ma quali sono le informazioni che vanno comunicate? Anzitutto quelle riguardanti i benefici per la salute derivanti da seguire le indicazioni scientifiche, come nel caso delle vaccinazioni, il cui scopo è evitare alle persone di ammalarsi. I benefici, tuttavia, non finiscono qui. Perché la prevenzione, come ha illustrato Francesco Saverio Mennini, “è anche una leva economica e sociale. Questo aspetto è stato e resta importante anche per coinvolgere le Regioni e spingerle ad ampliare e potenziare le loro politiche di prevenzione. Molti studi hanno dimostrato quanto per la comunità – e per chi l’amministra – sia vantaggioso migliorare i tassi di adesione a programmi di prevenzione e a programmi di vaccinazione, perché significa meno malattie, meno costi sociali e sanitari”.
Il capo Dipartimento della programmazione del ministero della Salute ha citato l’esempio del Covid: “Uno studio ha dimostrato come avere raggiunto la copertura vaccinale ad agosto 2021, anziché a dicembre 2021, abbia permesso al nostro Paese di risparmiare più di 200 miliardi in termini di PIL tra il 2021 e il 2022 in proiezione. Oltre a questo, c’è stata una forte contrazione dei ricoveri e dell’utilizzo di farmaci, tecnologie, cure visite e quanto necessario in caso di malattia, oltre a una riduzione del rischio di mancata produttività legata, ad esempio, ad assenze per malattia”.
Mennini ha quindi fatto sapere che il ministero della Salute, insieme al Mef, stanno lavorando per garantire un uso appropriato delle risorse in prevenzione. Anzitutto attraverso un lavoro di verifica e monitoraggio sull’utilizzo che le Regioni fanno dei fondi riservati a questa area, “perché sappiamo bene che non tutte le Regioni dedicato alla prevenzione, come previsto, il 5% del fondo sanitario a loro disposizione”. E poi prefiggendosi l’obiettivo di “incrementare gradualmente la quota percentuale di fondo sanitario da destinare alla prevenzione in ogni Regione fino a raggiungere il 7%. Parliamo di qualche miliardo di euro, quindi vanno considerati i vincoli di finanza pubblica – ha avvisato Mennini -, ma il Mef ha espresso la propria disponibilità a iniziare questo percorso”. Accanto a questo, “sempre in accordo con il MEF e con l’Europa, siamo lavorando per fare in modo che una parte della spesa corrente per la prevenzione non sia più considerata tale ma investimento. Questo ci permetterebbe di liberare delle risorse, di averne maggiori risorse non collegate al debito pubblico e, di conseguenza, di incrementare gli investimenti in prevenzione”.
Una buona notizia. Ma le risorse investite vanno ben usate e per Fabrizio d’Alba il presupposto per vincere questa sfida è che il sistema sia “nel suo insieme convinto che alimentare la cultura della prevenzione nella collettività sia una priorità e che dunque lo sia rendere i cittadini consapevoli e informati. Solo uniti, si vince”.
Una volta preso atto di questa convinzione, ci vuole organizzazione e strutture, ma per il presidente di Fedesanità Anci “soprattutto attenzione e metodo. Dobbiamo rendere i cittadini confidenti, il che significa fare in modo che abbiano fiducia in ciò che il Ssn gli propone. Per fare questo, dobbiamo raccontare. Parlare degli esiti positivi delle vaccinazioni e delle campagne di prevenzione, far comprendere ai cittadini quali sono i loro diritti ma – attenzione – anche quali sono i loro doveri. Questo vuol dire renderlo consapevole che il nostro può essere un Paese più sano e più sostenibile se c’è un cittadino responsabile”.
In che modo, però, vanno veicolate queste informazioni? E dove? Non solo nei presidi ospedalieri, ha sottolineato il presidente di Federsanità Anci. “Oltre il 60% del nostro Paese consiste in aree interne. Non possiamo pensare che la cultura della prevenzione per la collettività nasca nei presìdi ospedalieri, perché la sanità è sempre più proiettata verso una medicina e un’assistenza di prossimità, che si articola e si sviluppa in modalità diverse e che è lì, sul territorio, più vicina al cittadino di qualsiasi presidio. Mi riferisco agli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, alle farmacie ma anche alle strutture previste dal DM 77, Case e Ospedali di Comunità, dove lavorano diversi operatori esercitano le proprie competenze. Si tratta di un modello di prossimità ma anche di integrazione. Di luoghi in cui lavorano professionisti che hanno le competenze per alimentare la cultura della prevenzione, un compito al quale devono sottrarsi ma a cui non devono sottrarsi neanche le istituzioni locali”.
Attenzione, però, a non pensare che tutto sia risolto con il cittadino informato sui benefici della prevenzione. Perché, ha spiegato Ketty Vaccaro, da uno studio del Censis emerge come a un atteggiamento tendenzialmente più positivo del passato nei confronti delle vaccinazioni, non sempre corrisponda l’effettiva adesione alla vaccinazione stessa. “Questo è il nodo che dobbiamo affrontare. Capire cosa non permette ai cittadini di compiere il passo finale, che è quello di sottoporsi alla somministrazione del vaccino o allo screening”. Dall’osservatorio del Censis è emerso come una parte degli ostacoli, sui vaccini, sia da riscontrare in una sorta di stanchezza nei confronti della pandemia, che si è in qualche modo traslata sulla vaccinazione in generale. “Una sorta di meccanismo psicologico in base al quale la vaccinazione è roba da emergenza, quindi non più necessaria ora”. C’è poi, ha spiegato Vaccaro, “una percezione del rischio sottostimata, come se si pensasse che la vaccinazione non ci riguarda perché non il rischio da cui ci salva non è un nostro rischio. Si sottovaluta così non solo l’impatto sulla propria salute, ma anche il ruolo della prevenzione come strumento di sanità pubblica”.
Fondamentale è, per Vaccaro, “chiamare in causa gli interlocutori principali su questi temi, che sono i professionisti sanitari, perché dalle nostre indagini emerge chiaramente come, se è vero che le persone cercano risposte sul web o chiedono consigli in giro, è altrettanto vero che nel momento di decidere cercano il professionista sanitario, il medico, la competenza”.
Anche per Pier Luigi Lopalco occorre distinguere la crescente alfabetizzazione sanitaria di base con la comprensione profonda di queste informazioni, che poi è funzionale ad un cambiamento del comportamento. “Questo passaggio è più complesso perché entrano in gioco in diversi fattori. Anzitutto la fiducia nelle istituzioni che propongono la prevenzione. Il cittadino deve vedere che qualunque cosa accada, qualunque sia il vento politico o il colore del Governo, l’istituzione sanitaria parla sempre e solo una lingua, che è quella della verità scientifica. Purtroppo questo, con il Covid, è venuto meno e ha minato la fiducia del cittadino nei confronti dell’istituzione sanitaria”, ha detto l’esperto, già assessore alla salute della Regione Puglia in epoca Covid. Per Lopalco le istituzioni devono però fare uno sforzo in più anche per essere credibili, investendo sulle campagne vaccinali, “rendendo evidente al cittadino che le istituzioni per prime credono nella prevenzione, al punto da investirci così tante risorse. Perché una campagna vaccinale costa tanto, ma ha un ritorno nel tempo che, come già spiegato, va anche oltre la salute”.
Lopalco ha sottolineato come quello della prevenzione sia un tema da affrontare in logica One Health. “Del resto, tutti i più recenti problemi infettivi sono il risultato di un’alterazione dell’equilibrio fra salute animale, salute ambientale e salute umana. Avere un approccio di prospettiva globale è importantissimo, lo abbiamo anche questo visto con il Covid, anche per le vaccinazioni, ma anche più recentemente con l’arbovirosi. Questa estate ci si è molto concentrati sulle zanzare e su quelle malattie un po’ esotiche, che speriamo non diventino mai endemiche in Italia ma, a questo scopo, non basta la sanità, occorre fare disinfestazioni, sorveglianza, interventi ambientali e mettere in campo competenze che non sono uniche del mondo della salute umana”.
Sulla fiducia e la credibilità si è inserito l’intervento di Francesco Macrì, che ha citato l’effetto Hawthorne e l’effetto Rosenthal o di Pigmalione. “Il primo consiste nel vantaggio che si ottiene nel momento il cui il medico ha, nei confronti del paziente un atteggiamento di accoglienza, un atteggiamento empatico. Un atteggiamento che alimenta la fiducia del paziente”. L’effetto Rosenthal o di Pigmalione consiste, invece, nel modo in cui le aspettative del medico influenzano il comportamento del paziente portando questo ultimo, anche inconsciamente, a seguire un percorso per arrivare a soddisfare quelle aspettative. “Il paziente si sente chiamato in causa e risponde in modo collaborativo e impegnativo”.
Questi due metodi, “nessuno dei quali farmacologico, spiegano quanto sia importante il rapporto medico-paziente nel produrre l’efficacia di una strategia terapeutica oppure, in questo caso di una strategia vaccinale”, ha osservato Macrì, che ha però messo in guardia dai cambiamenti dei nostri tempi: “l’avvento della telemedicina rischia di modificare in modo sostanziale il rapporto medico-paziente. È un aspetto su cui è necessario aprire un approfondimento confronto, allo scopo di trovare le strategie necessarie per annullare questa distanza”.
Il lavoro da fare è evidentemente molto, ma sicuramente importante. La parola d’ordine resta collaborazione e fiducia. “La fiducia – ha detto Ugo Trama – la fai crescere creando un sistema quanto più fruibile per i cittadini, specialmente quando parliamo di vaccinazione. Questo significa creare anche momenti sinergici tra tutti gli operatori sanitari che poi sono concretamente impegnati ad offrire una prestazione sanitaria così importante come la vaccinazione”. Perché “il rapporto fiduciario dei cittadini – ha sottolineato il responsabile Politiche del Farmaco della Regione Campania – nasce anche se fortifichi e saldi il rapporto fiduciario tra Regione e operatori sanitari e tra gli operatori sanitari stessi. La fiducia deve essere reciproca e riguardare tutti. Senza dimenticare che ogni tipologia di cittadino ha un operatore sanitario specifico di riferimento, che può essere il pediatra o il medico di famiglia”.
Trama ha poi sottolineato come, “quando parliamo di vaccinazione, parliamo di erogare una prestazione sanitaria a un soggetto sano. È evidente che in una situazione del genere tanto più va fatta un’importante operazione di comunicazione corretta, scientifica e credibile perché il cittadino possa comprendere il valore di quel che gli viene offerto e accettarlo anche se allo stato attuale non ne avrebbe alcun bisogno per migliorare la sua salute”.
La prevenzione, come detto, è un investimento, i cui benefici a volte sono riscontrabili nell’immediato e altre volte nel lungo periodo, ma ci sono. Nel caso delle vaccinazioni, per Trama, “gli esiti della campagna possono essere esaminati già nel breve periodo. Analizzare i dati consentirà anche di strutturare la tipologia di gara e l’offerta vaccinale più adatta campo per l’anno successivo. Io credo sia anche giusto comunicare ai cittadini anche le informazioni inerenti le reazioni avverse ai vaccini, sia perché la trasparenza alimenta la fiducia ma anche perché pure sulle reazioni avverse si diffondono spesso notizie che non hanno alcun riscontro e valore scientifico”. Diventa dunque importante fornire agli operatori sanitari tutte le informazioni scientifiche perché possano rispondere, in modo corretto e trasparente, ai dubbi dei cittadini.
(di Lucia Conti)